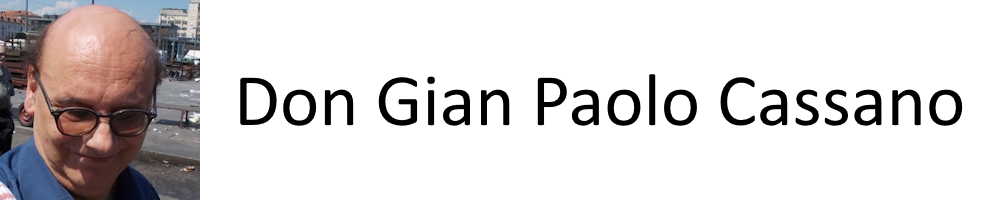“Fratelli e sorelle, buonasera!”; erano queste le prime parole, accolte dall’applauso di piazza San Pietro, il 13 marzo 2013 del nuovo papa eletto (primo gesuita nella storia), che, scherzando sulle sue origini, diceva di essere stato preso dai cardinali “quasi alla fine del mondo”. Un pontificato, il suo, che ha cambiato profondamente lo stile della Chiesa, che emerge dalla semplicità delle sue scelte, come quella per cu scelse di non abitare nel Palazzo apostolico, salvo le attività istituzionali del suo ministero e di continuare ad abitare in Casa S. Marta in Vaticano e che sorprese il mondo portando da sé in viaggio la borsa con il breviario ed il rasoio, pagando di tasca propria il conto, viaggiando in utilitaria, sempre a contatto con la gente (fino all’ultimo passando a Pasqua in papamobile tra i fedeli in piazza San Pietro)…
Jorge Mario Bergoglio era nato il 17 dicembre 1936 nel «barrio, quartiere» Flores della capitale, figlio di emigrati piemontesi: il nonno Giovanni Angelo è astigiano; la nonna piemontese-ligure; il papà Mario, nato a Torino, è ragioniere; la mamma Regina, di origini liguri, è casalinga. Jorge Mario si diploma chimico, poi, a 21 anni entra nel Seminario di Villa Devoto. Dopo il noviziato della Compagnia di Gesù, nel 1963 in Argentina si laurea in Filosofia. Insegna Letteratura e Psicologia poi si laurea in Teologia e il 13 dicembre 1969 è ordinato prete da Ramón José Castella arcivescovo di Cordoba e nel 1973 emette i voti perpetui. E’ stato Maestro dei novizi, professore, provinciale, parroco. Forte nel suo magistero è stato il riferimento agli scritti di Sant’Ignazio di Loyola, ma anche di San Pedro Fabro, di San Giovanni della Croce e Santa Teresina di Lisieux. Docente di Teologia, consultore provinciale della Compagnia e rettore del Collegio San Giuseppe, il 31 luglio 1973 padre Bergoglio è eletto provinciale dell’Argentina per sei anni, ma anche direttore spirituale e confessore a Cordoba, omo di vasta cultura e profonda spiritualità.
A 56 anni nel 1992 diviene ausiliare di Buenos Aires e il 28 febbraio 1998 è arcivescovo, primate di Argentina, ordinario per i fedeli di rito orientale sprovvisti di ordinario, gran cancelliere dell’Università Cattolica. Definisce la diocesi «la mia esposa». Vara un progetto per ri-evangelizzare Baires con comunità aperte, laici protagonisti, assistenza a poveri e malati: come primate lancia la campagna di solidarietà per il bicentenario dell’indipendenza (1816-2016). Il 21 febbraio 2001 viene nominato Cardinale. E’ stato presidente della Conferenza episcopale latino-americano (novembre 2005-novembre 2011).
Uno stile controcorrente, profondamente innovativo, che richiama sempre il cuore del Vangelo con profonda coerenza ed amabilità, che si esprime anche nelle telefonate personali a sorpresa del Pontefice a donne e uomini in situazioni delicate o di sofferenza che richiedevano una vicinanza di sincera amicizia o ponga gesti di amicizia quotidiana con ognuno, specialmente se in difficoltà. Suscita una piacevole sorpresa scoprire nella sua azione la bellezza e la novità dell’agire evangelico.
Così anche nel dialogo aperto e sincero con uomini e donne che sembrano distanti dalla fede (penso allo scambio con Eugenio Scalfari…).
E’ stato il Papa dei poveri, che ha fatto costruire bagni, docce e un ambulatorio per “barboni” e senzatetto sotto il colonnato del Bernini, che ha voluto una Chiesa povera e con i poveri, Chiesa ospedale, Chiesa in uscita”.
“La mia gente è povera e io sono uno di loro”, disse una volta per spiegare la scelta di muoversi con i trasporti pubblici invece che con l’autista, di abitare in un appartamento e di prepararsi la cena da solo nonostante la possibilità di vivere nella residenza episcopale all’epoca dell’arcivescovato a Buenos Aires.
E’ lui che ha voluto fortemente la Giornata mondiale dei poveri, a partire dal 2017, per sollecitare la Chiesa a “uscire” dalle proprie mura per incontrare la povertà nelle molteplici accezioni in cui essa si manifesta nel mondo di oggi. Il Papa ha più volte ribadito che i poveri hanno un posto privilegiato nel cuore di Dio, che è attento e vicino a ognuno di loro. Dio ascolta la preghiera dei poveri e, davanti alla sofferenza, diventa “impaziente” fino a quando non ha reso loro giustizia.
E’ stato il Papa della misericordia, indicendo il Giubileo straordinario della misericordia (8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016), tema che, forse, più di ogni altro ha caratterizzato il suo pontificato e che è destinato a rimanere. Diceva: “la misericordia di Dio è la nostra liberazione e la nostra felicità. Noi viviamo di misericordia e non ci possiamo permettere di stare senza misericordia: è l’aria da respirare. Siamo troppo poveri per porre le condizioni, abbiamo bisogno di perdonare, perché abbiamo bisogno di essere perdonati”. A quella vicinanza e tenerezza di Dio verso chi si riconosce bisognoso del suo aiuto. La misericordia come «l’aria da respirare», cioè ciò di cui abbiamo più necessità, senza la quale sarebbe impossibile vivere.
Il Papa che richiama alla coerenza evangelica nei confronti dei migranti, lui figlio di migranti monferrini emigrati in Argentina; non ha mai dimenticato le sue radici, ricordando come il dialetto (o lingua piemontese (che parlava correttamente) sia stata per lui la lingua con cui ha imparato la fede dai genitori e dalla nonna. “La fede – ha detto più volte – si trasmette in dialetto, cioè nel parlato familiare, fra nonni e nipoti, fra genitori e nipoti. La fede si trasmette sempre in dialetto, in quel dialetto familiare ed esperienziale appreso con gli anni.
Più volte ha ricordato che Dio “condivide il dramma dei migranti, è lì con loro, soffre con loro, piange e spera con loro”. Tuttavia, si rammarica il Papa di un vero e proprio paradosso dell’epoca moderna. Per questo ha volto compiere il suo primo viaggio proprio a Lampedusa, l’8 luglio 2013, toccato dal naufragio, nel canale di Sicilia, di un gommone di migranti.
Il Papa che ha insegnato la fraternità, anche nella scelta del nome (Francesco, per la prima volta nella storia) con un insegnamento forte e chiara nell’enciclica Fratelli tutti” (del 2020) tra cristiani nel dialogo con le religioni; penso alla dichiarazione sulla Fraternità Umana firmato insieme al Grande Imam di al-Azhar Ahmad al-Tayyib nel 2019, ad Abu Dhabi.
Il suo impegno ecumenico e per l’unità dei cristiani è emerso più volte già dal primo giorno, quando salutando i fedeli ricordava di essere il vescovo di Roma sigillata nell’amicizia sincera e dai tanti segni fraterni con il patriarca ecumenico Bartolomeo e nel corso dei 47 viaggi apostolici in 66 diverse nazioni e 40 visite pastorali in 49 differenti città o frazioni d’Italia.
Il Papa attento alla giustizia sociale ed al dono del creato, ad un’ecologia integrale in cui la preoccupazione per la natura, l’equità verso i poveri, l’impegno nella società, ma anche la gioia e la pace interiore risultano inseparabili, così come emerge nell’enciclica “Laudato si” (2015) e nell’esortazione apostolica “Laudate Deum” (2023)
Il 266° successore di Pietro ha mostrato il volto di una Chiesa vicina, capace di testimoniare tenerezza e compassione, accogliendo e abbracciando tutti, anche a costo di correre dei rischi e senza preoccuparsi delle reazioni dei benpensanti. Una Chiesa che non confida nelle capacità umane, nel protagonismo degli influencer che rimandano solo a sé stessi e nelle strategie del marketing religioso, ma si fa trasparente per far conoscere il volto misericordioso di Colui che l’ha fondata e la fa vivere, nonostante tutto, da duemila anni. La sua visione di Chiesa è espressa nell’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” (del 2013), un documento “programmatico e esortativo” in cui indica alla Chiesa di farsi compagna di strada di quanti sono alla ricerca di Dio, ribadendo la centralità della persona di Gesù come “primo evangelizzatore” e che invita a “recuperare una visione profetica e positiva della realtà, senza distogliere lo sguardo dalle difficoltà”. Fino ad arrivare all’ultima enciclica (“Dilexit nos, del 2024), un testo chiave del suo pontificato, dove, in mezzo a guerre e frammentazioni, ci sfida a guardare in alto e a fare scelte coraggiose, a volte perdenti, ma per il bene di tutti.
Forte è stato il suo impegno perché la Chiesa cattolica assuma sempre più il ritmo della sinodalità, di una Chiesa che cammina insieme al popolo, in ascolto del grido dell’umanità e impegnata a servire i più fragili.
È quel volto e quell’abbraccio che tanti hanno riconosciuto in lui venuto dall’Argentina, che aveva iniziato il suo pontificato andando a pregare per i migranti morti in mare a Lampedusa, e l’ha concluso immobilizzato in sedia a rotelle, spendendosi fino all’ultimo istante per testimoniare al mondo l’abbraccio di Dio vicino e fedele che verso tutte le sue creature.