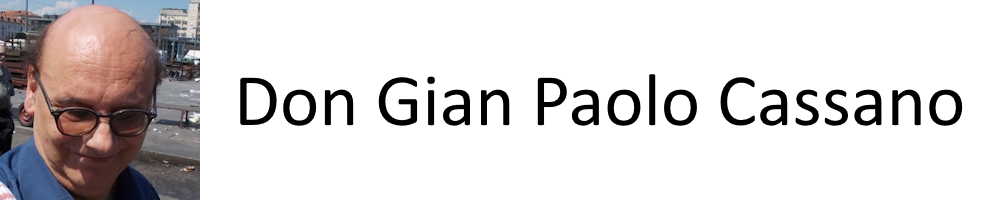In quel tempo, un dottore della Legge (…) disse a Gesù: «E chi è mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gèrico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva per quella medesima strada e, quando lo vide, passò oltre. Anche un levìta, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: «Va’ e anche tu fa’ così».” (Lc 10,25. 29-37)

Il brano evangelico, così bello e noto, è illustrato da Domenico Fetti (naturalista, del ‘600) che operò molto a Mantova alla corte dei Gonzaga, ove si ispirò a Giulio Romano, e per questo viene detto il Mantovano. L’opera (ne sono conservate altre simili), realizzata tra il 1618 ed il 1621, attualmente sta alla Gemäldegalerie di Dresda.
Il pittore non rappresenta, come avviene di consueto, il momento della narrazione in cui il samaritano guarisce il giudeo ferito a terra, ma quello appena successivo in cui lo issa sul suo asino (Lc 10, 34). Il chiaro messaggio moralistico va letto dunque come un’esortazione all’amore e alla pietà attraverso la ricezione del buon esempio fornito da Cristo (il samaritano), che dimostra pietà nei confronti del peccatore (il giudeo ferito) assalito dai ladri (il peccato) durante il ritorno da Gerusalemme (il Paradiso).
In primo luogo il dipinto è allo stesso tempo illustrativo e simbolico: illustrativo perché raffigura una scena comprensibile illustrandola ed è simbolico perché nel modo di raffigurarla utilizza particolari accorgimenti. Il viandante era incappato nei briganti, un evidente segno del male; in un contesto caratterizzato da alberi rigogliosi, un albero rinsecchito viene a rappresentarlo metaforicamente, quasi una simbolica analessi (cioè il ritorno indietro).
C’è poi un secondo elemento, nella centrale figura del samaritano che carica il malcapitato sul suo asino, simbolicamente posto davanti ad un albero rigoglioso (segno del bene che viene compiuto). Qui i personaggi, ben delineati, si evidenziano anche attraverso i loro colori. La direzione dell’asino, opposta a quella del sacerdote (o levita) che si intravede sullo sfondo ne sottolinea l’opposizione: i due in primo piano, l’altro in lontananza, i due ben evidenziati dai colori, l’altro sfumato in un coloro grigiastro. Su tutto appare la luce che, a prescindere dal contesto naturale, illumina la scena e che mette bene in chiaro il rapporto ombra-luce; non una luce descrittiva, ma una luce simbolica che non riflette i canoni naturalistici.